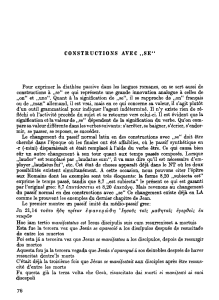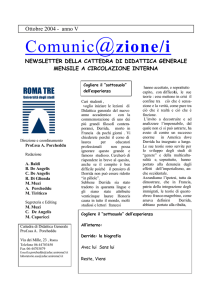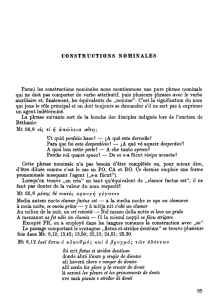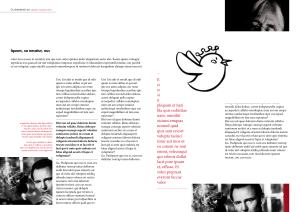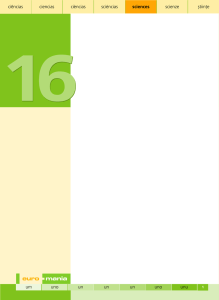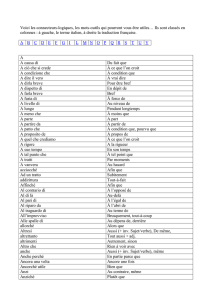1 - Progetto Fahrenheit

Il Cristianesimo come luogo nella filosofia di Jean-Luc Nancy
1
di Jordi Massó Castilla
"Räumen ist Freigabe der Orte, an denen ein Gott erscheint, der Orte, aus denen die Götter entflohen sind,
Orte, an denen das Erscheinen des Göttlichen lange zögert". (Martin Heidegger, "Die Kunst un der
Raum").
1. Introduzione: Heidegger e il Dio dell’ontoteología
Forse, l’ontoteologia, dopotutto non è altro che un discorso topografico. Vale a dire:
dopo aver sottomesso la metafisica alla Destruktion iniziata con Essere e tempo e dopo
aver rivelato che “ogni filosofia è teologia nel senso, originario ed essenziale, che il
rendere concetto (λόγος) l’ente nella sua totalità interroga il fondamento dell’Essere e
quel fondamento viene chiamato θεός, Dio”
2
, dopo tutto ciò, Heidegger comprende che
pensare alla relazione tra filosofia e teologia rinvia inevitabilmente ad un luogo (wohin):
“si potrà soltanto pensare, pienamente e in modo inerente a sé stessa, alla domanda: in
che modo Dio entra nella filosofia?, nel momento in cui, formulandola, si sia
sufficientemente chiarito il luogo in cui Dio deve entrare: la stessa filosofia”
3
.
Secondo tutto ciò, la Destruktion dell’ontoteologia, annunciata nei primi paragrafi di
Essere e tempo, adotta la forma di una doppia domanda. In primo luogo, quella
formulata da Heidegger, cioè, come entra Dio nella filosofia? Sarebbe a dire, come è
possibile che in una riflessione sull’ente nella sua totalità che interroga il fondamento
dell’essere irrompa quell’ente chiamato “Dio”? La risposta attraversa l’identificazione
di quell’ente supremo con il fondamento, operazione che fa dell’ontologia
un’ontoteologia. In secondo luogo, l’altra questione, sempre doppia e che rimane in
sospeso è la seguente: da quando la filosofia è un luogo e che tipo di luogo è. In questo
caso la delucidazione di questo discorso compromette quella topografia prima segnalata.
Si tratta, dunque, di studiare un luogo, quello filosofico, nel quale irrompe Dio,
contaminandolo. Come è risaputo, la meta che si prefigge Heidegger non è quella di
separare ontologia e teologia, ma quella di mostrare la radice comune in entrambe:
ovvero la postulazione di un fondamento come sostrato dell’ente. Se la filosofia deve
essere un luogo, non può essere se non quello nel quale viene portata a termine la critica
1
Questo saggio è stato tradotto da Valentina Zucchi e Cristina Coriasso Martín-Posadillo.
2
“Jede Philosophie als Metaphysik ist Theologie in dem ursprünglichen Sinne, daß das Begreifen
(λὀγος) des Seienden im Ganzen nach dem Grunde (d.h. der Ur-sache) des Seyns fragt und dieser Grund
θεὀς, Gott, gennant wird”, in HEIDEGGER, Martin: Gesamtausgabe. II. Abteilung, Vorlesungen 1919-
1944. Bd.42, Schelling: Vom wesen der menschlichen freiheit (1809). Frankfurt am Main, Vittorio
Klostermann, 1988, p. 87.
3
“Die Frage: Wie kommt der Gott in die Philosophie? Können wir nur dann sachgerecht
durchdenken, wenn sich dabei dasjenige genügend aufgehellt hat, wohin denn der Gott kommen soll -die
Philosophie selbst”, in HEIDEGGER, Martin: Identidad y diferencia / Identität und differenz. Barcelona,
Anthropos, 2008, p. 122.

di tale presupposto e nel quale venga recuperata la “domanda sull’essere”, la cui
dimenticanza può essere attribuita alla metafisica.
La filosofia pretende di svuotarsi di quel contenuto ontoteologico che ostacolava il
disvelamento dell’essere. Nonostante Dio non sia un tema ricorrente nell’Heidegger
anteriore alla “ svolta” (Kehre), è comunque implicitamente presente nei suoi scritti di
quel periodo un allontanamento, se non proprio un ripensamento, dalla (della)
dimensione teologica e di quella religiosa. Ciò nonostante, anche se nell’analitica
esistenziale del Dasein non trova spazio la dimensione religiosa dell’ente il cui modo di
essere è quello dell’interrogare, (la qual cosa confermerebbe la necessità di escludere
dal pensiero l’elemento teologico), in altri testi contemporanei ad Essere e tempo si
trova un elogio significativo del cristianesimo che, come vedremo più avanti, entra in
sintonia con un altro molto simile che possiamo trovare nell’opera di Jean-Luc Nancy.
In «Dell’essenza del fondamento» Heidegger sottolinea in che modo il cristianesimo
abbia introdotto “una nuova comprensione ontica dell’esistenza”
4
, in cui il concetto
greco di Kóσμος (“il Come nel quale l’ente è nella sua totalità”) comincia a designare
un determinato modo fondamentale dell’esistenza umana caratterizzata dall’essere “il
come di un modo di pensare che ha voltato le spalle a Dio”. Il Kóσμος cristiano è una
posizione dell’uomo davanti al cosmo, non teologica bensì antropologica, nella quale
risuona l’eco del concetto di “apertura” heideggeriano, visto che non si tratta di un
mondo-cosmo inteso come la totalità dell’ente, ma di un mondo come carattere
esistenziale del Dasein, come uno dei suoi modi esistenziali.
Anche se può sembrare paradossale, ciò che si è appena detto apre una via d’uscita
all’elemento teologico partendo dalla cosmologia cristiana ed invita a riflettere sulla
possibilità di una religione che non si appoggi su un fondamento ontoteologico. Si può
pensare ad una religione, più concretamente, ad un cristianesimo, che non si basi su un
Dio in quanto causa prima? Si può concepire un Dio al di fuori dell’ontoteologia? Con
questa domanda si apre una delle prime lezioni del corso che Emmanuel Levinas dedicò
alla questione di “Dio e l’ontoteologia”
5
. La risposta che Levinas offre è affermativa: sì,
si può pensare ad un Dio che stia al di fuori dell’ontoteologia nella misura in cui essa
venga subordinata ad un‘etica che superi la differenza ontologica – è oltre l’essere – e
il cui centro venga occupato dalla relazione con il prossimo dalla quale deriva la
responsabilità verso gli altri. In questo dialogo fra l’Io e l’Altro, nel quale non esiste mai
un’uguaglianza tra entrambi i termini – poichè la responsabilità nasce precisamente
dall’incommensurabilità di quell’Altro che fa di me stesso il suo ostaggio – se ne
presenta un terzo, situato al di là dell’essere e al di fuori della distinzione essere/ente,
identificabile con l’infinito e che non è altro Dio se non quello che è fuori
dall’ontoteologia
6
. Un Dio che non può essere pensato o, per lo meno, non se si parte da
una razionalità (λὀγος) che pensa a partire dall’ente e dall’essere (ontologia). In
Levinas, così come in Heidegger, la difficoltà risiede nel sottrarre Dio a quella
ontoteologia per poter penetrare così in un nuovo spazio, in un luogo inedito, in
quell’“oltre l’essere” levinasiano o quel “pensare senza Dio” che, dopo aver
abbandonato il Dio della filosofia, non essendo più causa sui, “è più vicino al Dio
divino”
7
, a quel Dio il cui arrivo, ne riparleremo più avanti, Heidegger si apprestava a
4
“Es ist aber kein Zufall, daß im Zusammenhang mit dem neuen ontischen Existenzverständnis,
das im Christentum durchbrach”, in HEIDEGGER, Martin: Gesamtausgabe. I. Abteilung, Veröffentliche
Schriften 1914-1970. Bd.9, Wegmarken. Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 2004, p. 143.
5
Cfr. LEVINAS, Emmanuel: Dieu, la mort et le temps, París, LGF, 1995.
6
Cfr., per esempio, LEVINAS, Emmanuel: Autrement qu'être. La Haye, Martinus Nijhoff, 1974,
p. 183.
7
“dem göttlichen Gott vielleicht näher”, in HEIDEGGER, Martin, op. cit. (2008), p. 152.

preparare, come diceva nella famosa intervista a Die Spiegel, quel Dio, l’unico o l’unica
cosa “che può salvarci”.
2. Nancy e i luoghi divini
Non abbandoniamo ancora questo lavoro topografico di ricerca dei luoghi. Di luoghi
che ormai non sono più fondati dagli dei che si costituiscono come il loro fondamento.
Di luoghi nei quali entrino ed escano gli dei ma senza rimanervici. Di luoghi che non
appartengono alla sfera ontoteologica ma che invece appartengono a quel “Dio divino”
del quale parlava Heidegger. Infine, di luoghi “divini” nei quali il divino non sia una
sostanza (oΰσία) intesa come “l’essere di un ente che è in sè stesso”
8
, ma un modo di
rapportarsi, di (ri)legarsi. Luoghi divini, Des lieux divins. Così si intitola un’opera di
Jean-Luc Nancy pubblicata nel 1987. In questo caso, il dato della data di pubblicazione
è rilevante poiché si potrebbero vedere in essa le basi di quel progetto filosofico
monumentale che Nancy porta avanti da più di tre lustri e che riceve il nome di
“decostruzione del cristianesimo”:
déconstruire le christianisme ne veut pas dire se contenter de la critique de l'illusion religieuse,
comme celle de Marx, de Freud, mais interroger ce que peut-être nous pouvons maintenant
découvrir au fond du christianisme, à savoir: retrouver le caché au coeur de la construction
chrétienne elle-même théologique, dogmatique, ecclésiastique, en se demandant si par là, il n'y
pas une ressource qui n'est pas religieuse, mais encore plus profonde que ça, ni philosophique,
ni religieuse, mais qui peut-être serait la grande ouverture de la pensée de l'Occident.
9
La decostruzione del cristianesimo mantiene una stretta somiglianza con la Destruktion
heideggeriana. Entrambe non sono altro che atteggiamenti, sempre positivi (Essere e
tempo, §6), nei confronti della tradizione, che non mirano alla sua distruzione ma che
vogliono recuperare ciò che originariamente c’era in essa e, che dopo secoli di dominio
dell’ontoteologia, è rimasto sepolto nell’oblio: la domanda sull’essere (Heidegger) e
nell’origine dell’apertura del pensiero occidentale (Nancy). Nel caso di quest’ultimo, la
decostruzione del cristianesimo è una “recherche consistant à désassembler et à analyser
les éléments constitutifs du monothéisme et plus directement du christianisme, donc de
l’Occident, afin de remonter (ou d’avancer) jusqu’à une telle ressource qui pourrait
former à la fois l’origine enfouie et l’avenir imperceptible du monde qui se dit
«moderne»”
10
.
Come proprio Nancy ha riconosciuto, il suo progetto decostruttivo si intravede in Être
singulier pluriel (1996), ma non raggiunge il suo intero sviluppo fino a La création du
monde (2002) e soprattutto fino ai due tomi della Déconstruction du christianisme (1.
La Déclosion, 2005; 2. L'Adoration, 2010), nonostante che le ramificazioni si estendano
ad un buon numero di articoli e ad opere come Visitation (de la peinture chrétienne)
(2001) e Noli me tangere (2003). Il punto di partenza di questo progetto è
l’affermazione heideggeriana che ogni ontologia è in fondo un’ontoteologia. La critica
8
“das Sein eines an ihm selbst Seinen lautet substantia”, in HEIDEGGER, Martin:
Gesamtausgabe. I. Abteilung, Veröffentliche Schriften 1914-1970. Bd.2, Sein und Zeit. Frankfurt am
Main, Klostermann, 1977, p. 120.
9
NANCY, Jean-Luc: «Il faut remettre l'homme dans un rapport infini avec lui-même», in Rivista
di Filosofia Neo-Scolastica, 4 (2007), p. 785.
10
NANCY, Jean-Luc: La Déclosion. París, Galilée, 2005, p. 54.

nei confronti di una “ontologia sostanziale” dovrebbe estendersi coerentemente a quei
presupposti teologici che dipendono da essa, poiché, in fin dei conti, il Dio delle
teologie e delle religioni è lo stesso Essere trascendentale e sostanziale dell’ontologia.
In entrambi i casi, quell’istanza si presenta come il fondamento di tutto ciò che esiste.
Nella sua opera, specialmente in quello che si conosce come il “primo Heidegger”, il
filosofo tedesco si dedica a reinterpretare concetti chiave della metafisica, tali come
verità, libertà, mondo, senso o esistenza, spogliandoli – o decostruendoli – del loro
(sotto)fondo sostanziale. Restava in secondo piano tutto ciò che è in rapporto alla
teologia che è embricata alla radice della metafisica. Il progetto della Decostruzione del
cristianesimo prende il testimone lì dove Heidegger lo ha lasciato: nella critica di quei
presupposti metafisici che stanno alla base del cristianesimo e, per estensione, delle tre
grandi religioni monoteistiche. Il procedimento seguito da Nancy per portare a termine
tale progetto, consiste nella scelta di un concetto capitale per il monoteismo, come per
esempio quelli di: rivelazione, resurrezione o creazione, per poi svuotarlo del suo
contenuto sostanziale apprestandosi così ad una nuova lettura in chiave ontologica,
partendo dall’ontologia dell’essere singolare plurale o dell’essere-con che
caratterizzano questo filosofo
11
. Ognuno di questi termini che viene decostruito dalla
decostruzione del cristianesimo può essere assimilato ad un concetto abituale nell’opera
di Nancy. Così, la creazione ex- nihilo è, per come viene reinterpretata da Nancy, una
nuova formulazione della es-posizione, parola che rinvia all’e-sistenza heideggeriana:
“«Nihilisme», en effet, veut dire: faire principe du rien. Mais ex-nihilo veut dire: défaire
tout principe, y compris celui du rien. Cela veut dire: vider rien (rem, la chose) de toute
principialité: c'est la création”
12
. E l’incarnazione, propria del cristianesimo, si avvicina
ad una nozione dell’essere-in-comune o partage che ha poco a che vedere con la figura
di Gesù Cristo e che invece ha a che vedere con l’e-sistenza e con l’essere-nel-mondo
(In-der-Welt-sein) heideggeriani: “nos savons bien que le coeur de la théologie
chrétienne est évidemment constitué par la christologie, que le coeur de la christologie
est la doctrine de l'incarnation, et que le coeur de la doctrine de l'incarnation est la
doctrine de l'homoousia, de la consubstantialité, de l'identité ou communauté d'être et de
substance entre le Père et le Fils”
13
. Di fronte a ciò, Nancy propone un nuovo senso per
questo mistero: “incarnation et resurrection déclinent ensemble une seule et même
pensée: le corps est l'événement de l'esprit. Son avènement, sa venue au monde, et sa
survenue, son irruption et son passage. Cela veut dire aussi: l'esprit en se tient pas hors
du monde, il s'ouvre au milieu de lui”
14
.
Qualcosa di simile succede con “categorie cristiane” come peccato o fede. Quest’ultima
probabilmente è una delle più presenti nell’opera di Nancy degli ultimi dieci anni
15
, e
viene descritta come “amour et courage, et/ou comme pensée de l'étant en totalité en
11
NANCY, Jean-Luc: Être singulier pluriel. París, Galilée, 1996.
12
NANCY, Jean-Luc: La Déclosion, op. cit., p. 39.
13
Ibídem, p. 219.
14
NANCY, Jean-Luc: L'Adoration. París, Galilée, 2010, p. 78.
15
Sebbene si debba considerare che la sua apparizione nel corpus nancyniano risale, almeno, agli
inizi degli anni ׳80. Così, in Le partage des voix la fede riceve un trattamento simile a quello che riceverà
all’interno della decostruzione del cristianesimo, poichè, per esempio, si presenta già in opposizone alla
credenza: “ce n'est pas la religion qui a donné à la philosophie une figure de l'herméneutique, c'est la
philosophie -c'est-à-dire ici l'onto-théologie comme l'entend Heidegger- qui a déterminé l'herméneutique
dans la religion. Le «cercle herméneutique» est sans doute (onto)théologique par nature et en toutes
circonstances. Ce qui par ailleurs en permet aucune conclusion sur l'«interprétation» religieuse hors de
l'onto-théologie (mais de quoi parlerait-on alors?). Peut-être faudrait-il se risquer à prolonger la note
précedente jusqu'à dire: la foi, quant à elle, pourrait bien être, malgré les apparences, tout à fait étrangère
à l'herméneutique (sans que soit par là comblé l'abîme qui la sépare de la philosophie, ou de la pensée)”.
In NANCY, Jean-Luc: Le partage des voix. París, Galilée, 1982, p. 17.

tant qu'«oeuvre» détachée de tout ouvrier”
16
. In quella che potremmo denominare
provvisoriamente la “religione ontologica” di Nancy – più avanti torneremo a parlarne –
la fede non è, come la credenza, un’adesione senza prove ad un senso determinato (Idea,
sostanza, Dio), ma un’apertura verso qualcosa che la trascende e che non è nient’altro
che il nulla, un’inoperosità in cui una finitezza comunica – questo è il laccio religioso –
con un’infinitezza che non si posizionerebbe oltre quella, come credeva Levinas, ma in
questa (transimmanenza), senza produrre nulla: né salvezza, né trascendenza, né
fecondità
17
. L’elenco dei termini cristiani sottomessi ad una decostruzione è talmente
vasto che il percorrerlo va oltre il proposito di questo articolo. Nonostante tutto, ci
accontenteremo per lo meno di segnalare in che modo Nancy scopra in questi ultimi un
elemento in comune. Egli sostiene che ognuno di loro, svincolato da una metafisica
della presenza che, unendosi alla teologia che fa di Dio il fondamento (ousia) arrivi ad
essere ontoteologia, si trasforma nell’indice di un lavoro etico: non fare della religione
l’adorazione di un Senso, di un ente supremo o causa sui, ma trasformarla in una prassi
in rapporto ad un senso al quale non bisogna legarsi e che non deve nemmeno essere
disvelato, ma di fronte al quale si deve rimanere aperti
18
. Ciò è quanto rivela la
rivelazione: che non esiste nulla di rivelabile, salvo la stessa rivelazione
19
. E ciò,
aggiunge, è (l’)adorabile.
Come si può osservare, nella decostruzione del cristianesimo tanto Dio quanto la
costellazione dei concetti creati a partire da esso perdono il loro fondo esistenziale se
vengono letti secondo la prospettiva dell’ontologia di Nancy. Il risultato di tutto ciò è un
allontanamento della sfera del divino dal pensiero, dato che questo cerca sempre il che
della rivelazione, il senso che si dis/ri-vela e non il come. Dio non può essere oggetto di
conoscenza, cosa per cui le prove della sua esistenza incorrono inevitabilmente
nell’assurdo. La teologia viene chiamata a perpetuare lo smarrimento della metafisica
quando, trasformata in ontoteologia, indaga sul fondamento ultimo dell’ente nella sua
totalità e lo situa in un Essere supremo. Nella filosofia di Nancy, Dio può unicamente
essere sentito in quanto presenza che si offre non ad essere colta in qualsiasi modo
(intuitivo, empirico, ecc.), ma ad essere sentita.
Di conseguenza, questo lavoro etico verso il quale veniamo chiamati, ha bisogno di un
nuovo rapporto con il divino. Ovviamente non si tratta di un’etica nel senso levinasiano,
cioè di un’etica che precede l’ontologia e secondo la quale il rapporto tra l’Io e l’Altro,
in cui si apre l’Infinitezza, trascende l’ontologico in quanto si ritrova oltre l’essere. La
prassi etica contenuta nella decostruzione del cristianesimo invece è inserita all’interno
di un pensiero ontologico che pensa, con Heidegger, che all’essere debba essere
riconosciuto il suo carattere verbale. Non l’essere (sostanza) ma essere (verbo
transitivo); essere, in termini di Nancy, "singolare plurale" o "essere-con" (être-avec),
per mezzo dei quali Nancy corregge Heidegger in un punto essenziale; il con, avec o mit
nasce con il Dasein, non dopo di lui, come sembrerebbe essere affermato in Essere e
tempo: il Dasein è sempre Mitsein, cioè, se il Dasein è l’esser “ci” (da), quel ci, quello
16
NANCY, Jean-Luc: La Déclosion, op. cit., p. 90.
17
“car la subjectivité amoureuse est la transsubstantiation même et que cette relation sans pareille
entre deux substances -où s'exhibe un au delà des substances- se résout dans la paternité”. LEVINAS,
Emmanuel: Totalité et Infini. La Haye, Martinus Nijhoff, 1971, p. 249. Senza dubbio, bisognerebbe
parlare a lungo del concetto levinasiano della fecondità/paternità e di come e fino a che punto quel figlio
che non “ho” ma che “sono”, non implichi una certa idea di “opera”, in modo tale che la intersoggettività
levinasiana si orienterebbe a quella produzione dalla quale vuole liberarsi Nancy.
18
NANCY, Jean-Luc: L'Adoration, op. cit., p. 16.
19
Nancy prende in prestito quest’idea dalle Lezioni sulle prove dell’esistenza di Dio di Hegel e la
introduce spesso nelle sue opere. Per esempio, in La Déclosion, op. cit., p. 214.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%


![Finale 2003a - [Verbe eternel o Dieu Sauveur.MUS]](http://s1.studylibfr.com/store/data/004281795_1-0b5cd06152b01919d518734601cee002-300x300.png)